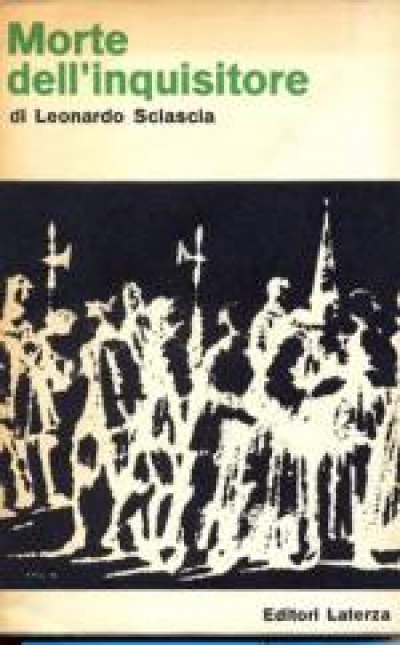Spesso il senso genuino di una formula si smarrisce volando di bocca in bocca, ma che quelle parole siano passate con tanta facilità da un poeta a un magistrato è cosa che dà da pensare. Chissà che ne avrebbe detto Pasolini, ci si chiede in questi giorni; eppure, davanti al fioccare degli «Io so», c’è un altro grande assente che dovremmo interpellare con rimpianto: Leonardo Sciascia, che pose il suo ostinato amore per la verità («Senza la verità saremmo perduti», diceva) sotto l’insegna schiva dello scetticismo, del non sapere appunto.
Due notizie editoriali - la pubblicazione per Adelphi del primo volume delle “Opere” (a cura di Paolo Squillacioti) e l’uscita del secondo numero della rivista di studi sciasciani «Todomodo» - danno occasione di rinfocolare le nostalgie. Che cosa avrebbe detto Sciascia, non c’è modo onesto di saperlo; vien da supporre, tuttavia, che nelle metamorfosi di quell’«Io so ma non ho le prove», sempre più lontane dall’azzardo poetico pasoliniano, avrebbe riconosciuto un’eco
familiare: è l’eterno sussurro dell’inquisitore, la voce del sospetto eretto a metodo e corroborato da una fede. Ma se Pasolini - il «fraterno e lontano» Pasolini - era l’eretico che adottò per una volta le parole dell`inquisitore, capita più spesso in Italia che siano gli inquisitori a gabellarsi per eretici.
Sciascia aveva intuito, rimeditando il Manzoni dei “Promessi sposi” e della “Colonna infame”, che l`eredità inquisitoria è la grande matrice del potere italiano in tutte le sue declinazioni, il tratto comune alle sue ideologie dominanti. Quanto più la si ricaccia nei secoli bui, tanto più
la si scopre familiare; per poco che la si menzioni, «molti galantuomini si sentono chiamare per nome, cognome e numero di tessera del partito cui sono iscritti», recita la prefazione a “Morte dell’inquisitore”, il libro che Sciascia più amava. Più ancora dell’intellettuale «organico» (che gli ricordava il concime) temeva l’intellettuale-inquisitore, e l’atroce logica circolare che dettava al presidente Riches, nel “Contesto”, i suoi sillogismi persecutori: l’errore giudiziario non esiste,
perché è il processo a Costituire il colpevole come tale; il solo potere legittimo si fonda sulla colpa, perché «dallo stato di colpa è facile estrarre gli elementi, della convinzione di reato più che dalle prove oggettive».
Il grande archetipo dell’Inquisizione - di cui, diceva Croce, il Sant’Uffizio non era che un’incarnazione contingente - Sciascia lo vide impresso sulle molte chiese e chiesuole nazionali: «Non c’è nessuna differenza tra un brigatista rosso e un inquisitore dei tempi dell`Inquisizione spagnola, non più di quanta ve ne fosse tra quest`ultimo e il convinto stalinista degli anni Cinquanta», confidò a Marcelle Padovani. Questo persecutore proteiforme poté osservalo all’opera sotto mille maschere: era lui che suppliziava Aldo Moro, si accaniva contro Enzo Tortora (che volle esser sepolto con una copia della “Colonna infame” introdotta
da Sciascia), fomentava un’antimafia fanatica e sospettosa, invocava la logica dell’emergenza - e la giustizia di guerra - come corso normale della vita della nazione. Per i cacciatori di eretici Sciascia aveva l’orecchio assoluto, sapeva riconoscerli dietro la maschera santimoniosa
del buon samaritano. All’amico Guttuso, comunista osservante, che tentava di dissuaderlo dal candidarsi con il Partito radicale, rispose così: «Ho scorso parecchi processi inquisitoriali, e specialmente del secolo Diciassettesimo: e ti assicuro che nella maggior parte di essi viene
fuori, autentica, sincera, commossa, la volontà degli inquisitori di salvare lanima degli inquisiti».
Sulle profezie politiche dei romanzi di Sciascia - il compromesso storico, il caso Moro - si è ragionato spesso; assai meno sulle chiaroveggenze che gli suggerì la sua ossessione per la giustizia: «Il 1984 di Orwell può anche, da noi, assumere specie giudiziaria. Ce ne sono i presentimenti, gli avvisi». Quando al simbolo della bilancia, ammonì, dovesse sostituirsi
quello delle manette, «saremmo perduti irrimediabilmente come nemmeno il fascismo c’è riuscito». E se non fosse che un momento giusto non c’era, verrebbe da dire che Sciascia è morto nel momento sbagliato, poco prima del crollo della Prima Repubblica, quando molti
evocavano la visione pasoliniana del «Processo al Palazzo». Le sue cronache ipotetiche su quella stagione, in cui tutti i suoi assilli di una vita sembrarono darsi convegno, sono una delle grandi pagine mancanti della cultura italiana del dopoguerra, e un`altra ragione di rimpianto.
La nostalgia di Pasolini è ormai un topos del discorso pubblico italiano, che si ripropone stancamente ogni novembre, tanto più che un pasolinismo di maniera, che si alimenta alle pagine più caduche - il fascismo dei consumi, l`omologazione, la pubblicità come lingua del
potere - ha cementato la falsa coscienza di una parte del ceto intellettuale, accompagnando
per vent`anni i suoi travisamenti. La nostalgia di Sciascia, invece, è più intermittente, e certe sue pagine decisive neppure circolano più. Se gli “Scritti corsari”, uno dei vangeli minori
dell’intellettualità italiana, non mancano mai dagli scaffali, “La palma va a nord”, preziosa antologia dello Sciascia polemista curata da Valter Vecellio, è introvabile dal 1982. Nel Paese degli inquisitori travestiti da eretici, ci sono eredità che è più prudente riscuotere.
Pubblicato su "La lettura" ,supplemento a Il Corriere della Sera 16/12/2012