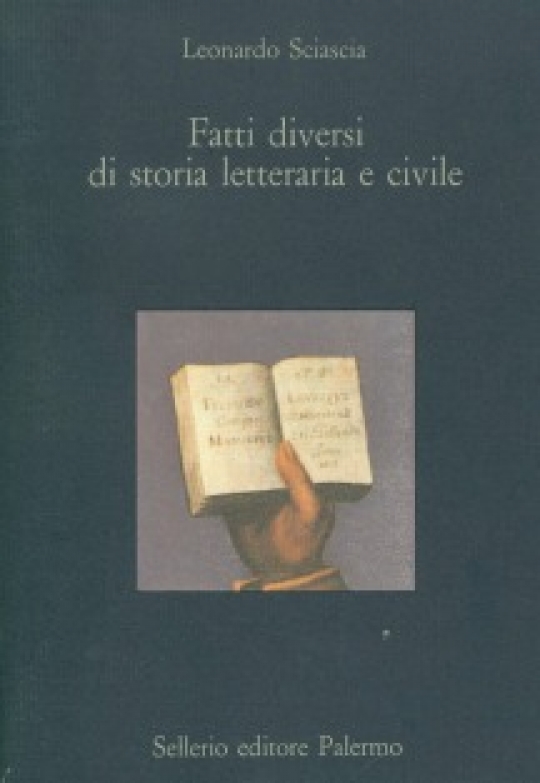Il lavoro metteva in scena la storia di un leggendario calzolaio messinese, il quale, constatato che gli autori di molti delitti rimanevano impuniti, aveva pensato di sostituirsi alle autorità che la giustizia avrebbero dovuto amministrare, ma in effetti non amministravano. E aveva quindi deciso di ergersi a giudice ed esecutore delle proprie sentenze, che erano ovviamente di morte.
Lo stesso De Stefani, pubblicando il suo lavoro alcuni anni dopo, indicò i testi ai quali si era ispirato, e che sono indicati da Sciascia nel suo saggio: i Voyages en Espagne et en Italie del padre gesuita Jean-Baptiste Labat (1730), l’Entretien d’un père avec ses enfants di Denis Diderot (1772) e il Saggio di versi faceti, e di prose di Carlo Gozzi (1774). A queste indicazioni Sciascia fa seguire i tre testi, o almeno quelle parti che riguardano direttamente la vicenda del calzolaio messinese. Si apprende così che il dialogo di Diderot – per esplicita dichiarazione dell’autore – si basa sul racconto di Labat. Ed è qui il caso di notare che il titolo completo dell’opera diderotiana è Entretien d’un Père avec ses Enfants, ou du Danger de se mettre au-dessus des Lois, e che nel testo originale il protagonista della vicenda è indicato in italiano, come “calzolaio de Messine”. Quanto a Gozzi – che potrebbe aver tratto la sua storia da Diderot –, dà un nome al ciabattino (Gianni Tina), lo trasforma in milanese e ambienta le sue imprese appunto a Milano. “Ma l’apologo (di Gozzi, ndr) non è più apologo, è fiaba che racconta una delle tante follie umane – scrive Sciascia in chiusura del saggio –. Non c’è più il problema della giustizia. Appunto come sempre in Italia: una follia, e non soltanto dei folli come Gianni Tina – il calzolaio di Milano – ma anche di quei folli che Diderot chiama saggi e che, non avendo per sé bisogno delle leggi, vigilano a che con relativa, approssimativa giustizia vengano applicate a coloro su cui cadono.”
Nei Voyages di Labat la credibilità della storia del calzolaio messinese si inscrive in un quadro di diffusa criminalità, rappresentata non soltanto dai numerosi briganti che infestano le campagne, ma anche da una delinquenza cittadina le cui azioni vanno dall’omicidio alle “concussioni, incettazione di prodotti (“monopoles”), false testimonianze, ruberie pubbliche e private”, reati che restano impuniti “o perché simili crimini vengono risarciti con denaro o perché chi li commette appartiene ad una sfera troppo elevata perché lo si possa toccare”.
Il “calzolaio di Messina” di Labat e Diderot, dopo aver commesso una cinquantina di omicidi, al termine di personalissime inchieste in cui è stato l’inquirente, il giudice e infine il boia, si costituisce al viceré. Questi, pur di far finire quello stillicidio di delitti misteriosi, con un pubblico bando aveva promesso una ricompensa di duemila scudi a chiunque favorisse la cattura dell’assassino o, a quest’ultimo, lo stesso compenso e la libertà, a condizione che si costituisse; e aveva confermato la sua promessa con un solenne giuramento in chiesa. Avendo probabilmente esaurito la lista degli omicidi da commettere, e nel timore di essere scoperto, il calzolaio decide di far visita al viceré: al quale rimprovera di non aver punito i delinquenti da lui ‘giustiziati’, e aggiunge che per questa omissione egli, il viceré, meriterebbe la stessa pena. Accetta quindi i duemila scudi e, per evitare possibili vendette, viene trasferito con tutta la famiglia nella Repubblica di Genova.
Gianni Tina, invece, da ragazzo è al servizio di un cancelliere e si infarcisce la mente di atti giudiziari: al punto di cominciare a minacciare chi gli faccia qualche sgarbo di intentargli un processo seguito da terribili pene. Non potendo tuttavia mettere in atto le sue minacce sulle persone, si sfoga sugli animali domestici, ‘colpevoli’ di furti o piccoli incidenti: e finiscono – galline, gatti, pollastri – sui patiboli che il ragazzetto si diverte a costruire. Il cancelliere, stanco delle sue mattane, lo rispedisce al padre, un ciabattino, dal quale il giovane impara il mestiere. Dopo la morte del genitore, tuttavia, non accontentandosi di esercitare le sue funzioni ‘giudiziarie’ sugli animali, il ragazzo comincia a farlo sulle persone, e porta a termine una trentina di accuratissime inchieste, concluse con condanne capitali e conseguenti ‘esecuzioni’. La sua ‘carriera’ si interrompe quando viene catturato, subito dopo la sua ultima impresa, dai familiari dell’ucciso. Per via dei contorti ragionamenti che fa con gli inquirenti, il governatore vuole conoscerlo: e al termine del colloquio, giudicandolo pazzo, decide di farlo rinchiudere in carcere a vita.
Il “calzolaio di Messina” di Labat e Diderot da un lato, e il ciabattino milanese di Carlo Gozzi dall’altro, decidono di fare giustizia per conto della società: quelli che puniscono non sono infatti crimini diretti contro di loro. In altri casi, tuttavia, la spinta a farsi giustizia da sé può scattare nelle vittime, o nei familiari delle vittime, di reati i cui responsabili restano impuniti. E la reazione di queste persone, dapprima strettamente privata, può a poco a poco gonfiarsi e stravolgersi, fino a confondere la vendetta-giustizia individuale con una presunta ‘giustizia’ fatta anche per conto della società.
Sul rischio – sul pericolo, per dirla con Diderot – di mettersi al di sopra delle leggi per vendicare un torto subìto, negli Stati Uniti nel 1974 fu girato un film che ottenne un grande e anche preoccupante successo di pubblico, tanto da diventare il primo di una serie (Death Wish, in Italia Il giustiziere della notte, regia di Michael Winner, protagonista Charles Bronson). E, sempre negli Stati Uniti, l’anno successivo fu pubblicato un romanzo salutato da un largo consenso di pubblico, che si estese rapidamente a molti altri paesi: Ragtime di E.L. Doctorow. Ambientato soprattutto a New York nelle prime due decadi del XX secolo, il romanzo mette in scena una straordinaria serie di personaggi storici, le cui vicende si fondono con quelle di personaggi di fantasia. Ed è così che nel libro fanno la loro comparsa, tra gli altri, Henry Ford e John Pierpont Morgan, Sigmund Freud e Harry Houdini, Emma Goldman e Alexander Berkman e Henry Clay Frick, Stanford White ed Evelyn Nesbit e Harry K. Thaw, Teddy Roosevelt e Woodrow Wilson, Francesco Ferdinando d’Asburgo con la moglie Sofia, Booker T. Washington e Andrew Carnegie, ma anche i protagonisti della rivoluzione messicana in corso in quegli anni, Pancho Villa e Francisco Madero, Venustiano Carranza ed Emiliano Zapata. I personaggi, tutti di fantasia, intorno ai quali Ragtime finisce per ruotare sono comunque quelli dei componenti della Famiglia e di Coalhouse Walker Jr., un pianista nero.
Non è il caso di narrare la vicenda di Coalhouse Walker Jr. Basterà dire che, dopo aver cercato di ottenere giustizia per una prepotenza che ha avuto tragiche conseguenze, il pianista mette insieme una banda e cerca di farsi sanguinosamente giustizia da sé. Colpisce, del personaggio, il nome di battesimo: “Coal-house”, ossia casa, magazzino o deposito del carbone. Coalhouse potrebbe essere il cognome di un americano di una certa importanza, utilizzato negli Stati Uniti come nome di battesimo, al pari di altri più illustri cognomi, come Jefferson o Washington. Ma nella realtà non è mai esistito un personaggio importante di cognome Coalhouse.
Coalhouse Walker Jr. sembrerebbe quindi una creazione della fantasia dell’autore di Ragtime. Il condizionale è d’obbligo perché in effetti, prima di entrare, grazie a Doctorow, nella storia della letteratura americana, Coalhouse Walker Jr. era già vissuto due volte, alcuni secoli prima e al di qua dell’Atlantico: prima nella storia, poi nella letteratura tedesca. Il pianista nero è, infatti, la seconda incarnazione letteraria di Hans Kohlhase, il quale, tra il 1532 e il 1540, terrorizzò la Germania in cui era in pieno sviluppo la Riforma protestante. Dalla sua vicenda, tra il 1808 e il 1810 Heinrich von Kleist trasse Michael Kohlhaas, secondo alcuni critici il più bel racconto della letteratura tedesca.
Kohlhaas: cognome altrettanto singolare che il nome Coalhouse. “Kohl” significa infatti cavolo e “hase” lepre. Prescindendo dai significati delle parole inglesi e tedesche, e dalle loro possibili combinazioni, Coalhouse e Kohlhaas hanno una pronuncia molto simile. Ma questo non è che il primo punto di contatto tra i due personaggi. Basta infatti leggere il romanzo di Doctorow e il lungo racconto di von Kleist per rendersi facilmente conto che Coalhouse Walker Jr. non è altri – ovviamente mutati tempi, luoghi, razza, mestiere e condizioni sociali – che un secondo Kohlhaas: appunto un Kohlhaas-Coalhouse… Jr.
Niente di nuovo, si potrebbe commentare, anche perché la storia della letteratura è piena di prestiti: come si può leggere in un libro sull’argomento pubblicato un paio di anni fa (Luigi Mascheroni, Elogio del plagio. Storia, tra scandali e processi, della sottile arte di copiare da Marziale al web, Nino Aragno Editore, Torino, 2015.) Nel libro non è menzionato il prestito contratto da Doctorow nei confronti di von Kleist: segnalare tutti i plagi della storia della letteratura è, del resto, impresa probabilmente impossibile. In ogni caso non ho mai trovato, in testi di critici e giornalisti che hanno scritto del romanzo di Doctorow, un qualche accenno all’origine del personaggio di Coalhouse Walker Jr.
Doctorow, tra l’altro, non ha fatto quasi nulla per nascondere la derivazione del suo Coalhouse dal Kohlhaas di von Kleist; ma al tempo stesso, per quanto ne so, non lo ha mai ammesso. Ed è strano, perché in Ragtime la vicenda di Coalhouse Walker Jr. è in effetti il tronco, o uno dei principali rami, del grande albero che è il bel romanzo di Doctorow. Ma, proprio per questo, si resta allibiti nel leggere, in un’intervista concessa a Fernanda Pivano nel 1985, e riportata nei Diari 1974-2009 della grande americanista (Bompiani, Milano, 2010), che lo scrittore americano non avrebbe fatto alcuna ricerca per scriverlo. E vale la pena di riportare per esteso lo scambio di battute tra i due:
“I tuoi libri sono molto complessi. Come li componi?”
“Quando scrivo un libro trovo le cose mentre ne ho bisogno. È una situazione molto bella, si diventa come magneti per l’informazione di cui si ha bisogno per continuare. Viene dall’aria e ci si posa sulle spalle, vola dal cielo e cresce dalla terra, e noi la mietiamo. Si trova una fotografia importante o si sente una conferenza o l’occhio si posa sul titolo di un libro o in una vetrina o si vede una faccia per strada… si coglie qualsiasi cosa di cui si abbia bisogno.”
“Ma per Ragtime avrai dovuto fare delle ricerche.”
“No. Capisci, non sono un erudito. La mia ricerca è molto soggettiva. A volte invento qualcosa e poi faccio qualche ricerca per vedere se posso sostenerla.”
Appena lette queste parole, però, viene l’irresistibile tentazione di citare William Faulkner che, in un’intervista riportata da Luigi Mascheroni nel suo libro, dichiarò, a proposito delle fonti di ispirazione: “A volte credo che le idee fluttuino nell’aria come polline, che feconda menti simili tra loro che non sono mai entrate in contatto diretto”. (Il polline: ecco ciò che intendeva Doctorow, quando parlava di qualcosa che “viene dall’aria e ci si posa sulle spalle…”.)
Ma, dopo quest’incursione nella letteratura americana e in quella tedesca, torniamo a noi: ossia all’Italia e alla nostra letteratura, da dove avevamo cominciato, con Il calzolaio di Messina sciasciano. E andiamo a leggere il secondo capitolo de I promessi sposi: “Renzo intanto camminava a passi infuriati verso casa, senza aver determinato quel che dovesse fare, ma con una smania addosso di far qualcosa di strano e di terribile. I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che, in qualunque modo, fanno torto altrui, sono rei, non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi. Renzo era un giovine pacifico e alieno dal sangue, un giovine schietto e nemico d’ogni insidia; ma, in que’ momenti, il suo cuore non batteva che per l’omicidio, la sua mente non era occupata che a fantasticare un tradimento…”
E anche a me viene spontaneo fantasticare: se avesse avuto cinque o sei amici di fegato, e non i soli Tonio e Gervaso, buoni tutt’al più come testimoni di un tentativo di matrimonio di sorpresa, Renzo Tramaglino avrebbe potuto seguire l’esempio di Michael Kohlhaas e precedere Coalhouse Walker Jr.?
Parafrasando Madame Roland, si potrebbe dire: “Giustizia, quanti delitti si commettono in tuo nome!”. E non solo da parte di chi la giustizia dovrebbe amministrare e non lo fa – commettendo quindi, sia pure per omissione, un delitto – ma anche da parte degli offesi che, non ottenendola, decidono di farsela da soli. E se si è portati a comprendere il “pervertimento […] (de)gli animi degli offesi”, molto più difficile è comprendere o addirittura giustificare le ragioni di certuni che si autoeleggono giustizieri, siano essi i cinematografici “giustizieri della notte” americani, o “il calzolaio di Messina” del saggio di Sciascia.
Per concludere, sempre con quell’affresco impietoso dell’Italia – del XVII secolo e di sempre – che per Leonardo Sciascia è il romanzo manzoniano, al settimo capitolo si leggono queste parole rivolte da Agnese a Renzo, che in preda all’ira minaccia – ma il suo è l’abbaiar d’un cane che non morde – di uccidere don Rodrigo: “ ‘Non dite queste cose, per amor del cielo,’ riprese ancora in fretta Agnese, abbassando la voce. ‘Non vi ricordate quante braccia ha al suo comando colui? E quand’anche… Dio liberi!… contro i poveri c’è sempre giustizia’ ”.
Ogni lettore è libero di interpretare come crede, in tutte le loro possibili implicazioni, le ultime parole di Agnese. (O di Manzoni?)
Euclide Lo Giudice