Denis Diderot
Paradosso sull’attore
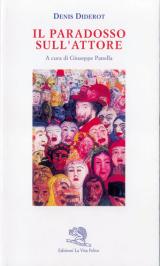 |
Paradosso sull’attore A cura di Giuseppe Panella Ottobre 2002 |
|
il libro Il libro, smilzo nelle sue novanta pagine di testo, era uscito in una collana a carattere fortemente popolare che, però, aveva avuto il pregio fin dall’inizio di proporre ad un pubblico il più vasto possibile testi classici nell’ambito della cultura mondiale in un’edizione dimessa che aveva, per questo, costi fortemente ridotti. Sciascia rimase colpito in maniera straordinaria dall’opera di Diderot tanto da parlarne in ogni occasione come della sua personale “iniziazione” all’Illuminismo e alle sue forme di razionalità dialettica. Più che l’argomento trattato (anche se su di esso ternerà a più riprese nella sua scrittura saggistica) lo scrittore di Racalmuto apprezzava il modo di argomentare e lo stile di Diderot. La tesi contenuta in questo aureo libello è piuttosto nota per il suo carattere paradossale: l’attore (che in francese si traduce più esaustivamente come comédien piuttosto che come acteur) è tanto più bravo ed efficace sul palcoscenico quanto meno “sente” il personaggio e interpreta la parte per imitazione dei suoi atteggiamenti e dei suoi sentimenti. Se l’attore imita il personaggio riesce a renderlo efficacemente, se vuole entrare dentro di esso, comprenderlo, riviverlo, in sostanza “diventare” il personaggio da lui interpretato, risulta fiacco e inattendibile. La finzione (soltanto quella scenica?) è di gran lunga più credibile e verosimile della realtà (umana). Ciò contraddice – va da sé – tutti gli insegnamenti che gli attori ricevono nelle scuole di teatro prima di calcare il palcoscenico, soprattutto è in opposizione al modello di immedesimazione nel personaggio che contraddistingue il Metodo di recitazione lanciato ad inizio secolo da Kostantin Stanislavskij e poi ripreso in America da Lee Strasberg per il suo ormai mitico Actor’s Studio. L’edizione del testo di Diderot curata da Giuseppe Panella intende rendere conto in sede di Prefazione di tutti questi problemi (estetici, storici, teorici, teatrologici) e contiene anche una ricostruzione della carriera letteraria di Alessandro Varaldo all’interno della storia del romanzo italiano del Novecento, in particolare nell’ambito della narrativa poliziesca che in Italia dal colore della copertina della sua principale collana a diffusione nazionale viene detta “gialla” a partire dal 1929. Giuseppe Panella |
|

